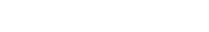Partiamo dai fatti. Il 10 settembre 2006, alcuni studenti di una scuola di Torino si filmano mentre maltrattavano un compagno di classe affetto da autismo e caricano il video su Google Video. Il filmato resta sulla piattaforma Google Video senza essere notato fino al 5 novembre 2006, quando un blog italiano, facendovi riferimento, ne scatena la diffusione in modo virale. Scattata la denuncia da parte dell’associazione milanese Vivi Down, il 7 novembre la Polizia Postale di Roma richiede a Google, attraverso canali istituzionali, la rimozione del video, che avviene il giorno stesso.
A quel punto, Google collabora con la Polizia locale per l’identificazione della persona che lo ha caricato e dei responsabili dell’odiosa vicenda di cyberbullismo, per usare un goffo neologismo. Successivamente, questa persona è condannata a 10 mesi di lavoro al servizio della comunità, insieme a diversi altri compagni di classe coinvolti.
Passano tre anni e nel 2009 la Procura di Milano rimanda a giudizio 4 dirigenti di Google – David Drummond, Arvind Desikan, Peter Fleischer and George Reyes – per diffamazione e violazione del Codice Italiano in materia di protezione dei dati personali. Il giudice di primo grado assolve i quattro imputati dall’accusa di diffamazione e, soprattutto, riconosce l’assenza da parte di Google Video di un obbligo di monitoraggio preventivo dei contenuti caricati dagli utenti. Ed è inevitabile che sia così: il ruolo delle piattaforme di hosting è quello di un intermediario, che ospita i contenuti caricati dagli utenti che desiderano archiviare questi video per motivi personali o condividerli con altri. La piattaforma non ha tecnologicamente nessun possibile controllo editoriale sui contenuti che ospita: la distinzione tra chi crea e condivide i contenuti e chi fornisce l’infrastruttura per renderli disponibili è netta.
Ciononostante, Drummond, Fleischer e Reyes vengono condannati nel febbraio del 2010 per violazione dell’articolo 13 del Codice italiano della privacy, adducendo come motivazione una insufficiente informativa fornita dalla piattaforma alla persona che ha caricato il video, attribuendo peraltro un profilo penale alla violazione rilevata (nonostante l’articolo 13 non abbia rilevanza penale). Ad abundantiam – l’Italia è anche questa, culturamente parlando – il giudice di primo grado cita il “profitto” come intento criminale che avrebbe mosso Google e i suoi dirigenti al comportamento omissivo.
Il web non è un far west, ed è opportuno che – su richiesta – nel novembre 2006 Google abbia immediatamente rimosso il video incriminato. Google Video dispone peraltro di un’informativa sulla privacy agli utenti, contenuta nei “Termini e Condizioni”, che rende moto esplicito che chiunque carichi un video deve avere il consenso delle persone riprese nel video stesso e rispetta la direttiva europea 70/2003 sul commercio elettronico, la quale non prevede per l’infrastruttura il monitoraggio preventivo dei contenuti.
Cosa c’è da aspettarsi dal processo d’appello? La vicenda riguarda non solo e non tanto i dirigenti di Google. Se la sentenza di primo grado fosse confermata, di fatto l’Italia dichiarerebbe “fuorilegge” la stessa architettura assiologia del web, basata sulla neutralità dell’infrastruttura e la non discriminazione rispetto al merito dei contenuti caricati
Benvenuto!Collegati al tuo account