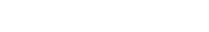I giornali sono in crisi? L’editoria fa acqua da tutte le parti? Il presente e ancor più il futuro dell’informazione sono un punto interrogativo? Ok, a quanto pare i big a stelle e strisce hanno da sfornare una novità: l’imprenditore non si fa più editore, ossia non entra nell’azionariato di un giornale (in crisi), né investe in pubblicità (un mercato che non tira più) – stiamo parlando del mondo cartaceo – ma “si fa l’impresa”, costruisce il suo giornale “aziendale”. Però “attention”, il tutto è on line, viaggia sul web: per la serie “owned media” (ossia un media “di proprietà”), oppure, se preferite, “corporate journalism” (giornalismo di una “corporate”, una grande azienda). La traduzione in realtà è avvenuta, pochi mesi fa, a Richmond, in California, dove ha sede il quartier generale della Chevron, colosso petrolifero da 250 miliardi di dollari. E Richmond è passate alle (tristi) cronache per il “botto” che un paio d’anni fa mandò in ospedale ben 15 mila persone, su un totale di centomila abitanti, più di 1 su 7.
Cosa hanno tirato fuori dal cilindro, a questo punto, i top manager targati Chevron? Per rifarsi il look e riacquistare la fiducia della gente, a gennaio è partito “The Richmond Standard”, un giornale on line di “cose belle e positive”, per di più scritte da alcune grosse firme che fino al giorno prima sparavano cannonate a bordo dei più (ex) accorsati quotidiani: è il caso, ad esempio, del neo direttore, Mike Aldax, “scippato” dai petrolieri alle colonne del San Francisco Examiner (dove si occupava di cronaca nera). Da rilevare che lo stesso Aldax lavora anche per la “Singer Associates”, un’azienda di pubbliche relazioni specializzata in “issues management” e “brand reputation”, ossia il marketing unito alla “ricostruzione d’immagine” proprio per aziende che attraversano fasi di crisi o hanno grossi problemi da fronteggiare (come Chevron dopo incendi e fumi del 2012). E la figura di Aldax 2 (ossia il giornalista che diventa pr e superufficio stampa aziendale) è emblematica di come ovunque il rapporto tra addetti all’informazione tradizionale (giornalismo carta, radio, tivvu) e alla comunicazione si sta rapidamente spostando a favore della seconda: secondo recenti ricerche condotte proprio negli Usa, se il rapporto dieci anni fa era di 1 giornalista e 3 comunicatori, oggi il rapporto è di 1 a 5 (e anche in Italia il rapporto va in tal senso, con un fatturato fatto segnare dal settore della comunicazione in crescita nonostante la crisi, pari a 1 punto del nostro Pil).
Torniamo ancora a bomba – è il caso di dirlo – ossia al tipo di prodotto confezionato dai redattori (sic), o meglio dagli yes-pr man del Richmond Standard. I quali raccontano storie belle e positive, dal ragazzo che salva la donna in overdose, al liceale mingherlino che si trasforma in incredibile Hulk e solleva 134 chili, cittadini, politici, sportivi e imprenditori bravi e coraggiosi, una città laboriosa e proiettata verso il radioso (e senza nubi tossiche) futuro. Il massimo viene raggiunto nella rubrica “Chevron speaks”, dove l’azienda risponde alle critiche ovviamente “infondate e inesatte” messe artatamente in giro dagli altri media o dai concorrenti, o da qualche cittadino che non ci sta. E così, per miracolo, ecco mamma Chevron rassicurare che “l’ampliamento della raffineria ridurrà l’inquinamento e darà posti di lavoro”. Oppure, ecco servito il grande scoop: “le nubi sulla raffineria della Chevron erano in realtà innocue nuvole di vapore”. Qualche volta, però, fanno i duri e dai take passano ai tackle: ad esempio quando Aldax stesso inforca il web per accusare il sindaco di Richmond di “fare la guerra alla Chevron”, attraverso un’azienda di pubbliche relazioni “sospettata di ingaggiare finti manifestanti per protestare davanti alle sede del consiglio degli azionisti Chevron”.
Non manca, però, chi storce il naso e sente lontano un miglio puzza di bruciato (anche stavolta, è il caso di dirlo, per le vicende di casa Chevron). Osserva un analista di media, Ken Doctor, a proposito degli animatori del giornale on line di Richmond: “Non ci sono ormai molte cose che mi lasciano esterrefatto, ma loro sì”. Rincara la dose John Upton a bordo dell’agguerrito (uno dei pochi rimasti) sito Griest: “Chevron crea un suo outlet di news per una povera città che essa stessa inquina. E’ roba di semplice auto propaganda scritta dagli scagnozzi della compagnia. Aspettiamo presto che nuove iniziative prendano corpo in altri territori di conquista della Chevron: a quando un Ecuador Standard?”. Bordate anche da una storica testata locale, il “San Francisco Chronicle”, che sottolinea – per fare un solo esempio – come Aldax & C. non tengano in alcun conto cittadini e attivisti che contestano le politiche della raffineria. Le critiche del Chronicle vanno poi al cuore del problema: “C’è ormai una totale compromissione fra due mestieri – viene sottolineato – molto diversi pur se per certi versi simili, comunicazione e informazione. Una svela, l’altra vela”. La classica dicotomia tra giornalismo tradizionale (almeno una sana cronaca, senza pretendere controinformazione o investigazioni spinte) e ufficio stampa/pubbliche relazioni. Riprendiamo il filo del discorso sul perchè si sta creando l’orrendo mix; o più precisamente perchè il primo sta soccombendo al secondo, ovvero perchè sta morendo l’informazione e proliferando la comunicazione. Ci aiutano, in questo percorso, le parole di un altro docente statunitense, Edward Wasserman, che insegna alla Scuola di giornalismo dell’università di Berkeley: “L’idea che la seconda compagnia petrolifera crei un quotidiano on line riporta all’idea dei magnati e uomini d’affari proprietari di giornali per perseguire i loro fini personali, finanziari o politici. Ora che i giornali d’opinione lottano per sopravvivere, ecco affacciarsi siti on line di news con i quali raggiungere, per vie diverse, gli stessi obiettivi”. In sostanza, il Richmond Standard è l’ultimo prodotto di una nuova gamma di mezzi d’informazione partoriti nel ventre ricco degli States, media che hanno la doppia caratteristica, ossia di essere locali e digitali. I portabandiera di tale “new wave”, sempre entro i confini statunitensi, sono Patch e Dnainfo.com. Spiega John Upton: “Il Richmond Standard è un sito giornalistico iperlocale che ha tutti i crismi del tipico sito Patch”.
Un nome e una breve ma già intensissima storia, quella di casa “Patch”, una piattaforma su cui si accalcano la bellezza di 900 siti locali, stando ai dati a tutto maggio 2014. Così un flash da wikipedia: “Patch.com è una piattaforma Usa indipendente di notizie e informazioni, che opera dal 2007 in 23 stati americani, potendo contare su 906 siti web locali e iperlocali. L’operatore del servizio si chiama Patch Media Corporation”. Ormai un colosso, passato da Time Warner ad Aol per 7 milioni di dollari, con investimenti subito stanziati e pari ad oltre 50 milioni di dollari per la start up del network Patch.com. Ora il controllo azionario è nelle mani di un altro big, Hale Global. “Una rete di sigle sempre più potente, in grado di controllare e dirigere le nuove vie dell’informazione – notano alcuni analisti dell’università di Berkeley – e poco importa se si tratta di informazione autentica o no. Quel che conta è il numero di utenti che raggiungi e la possibilità di influenzare le loro coscienze e conoscenze”. Quanto tutto ciò abbia a che fare con il giornalismo “tradizionale” e ormai in via di estinzione, of course, non è un problema.
Sono le aziende, i grandi gruppi a dirigere i giochi; e, soprattutto, a investire quote sempre maggiori dei propri budget negli owned media. “Cresce il numero delle aziende che possono diventare anche media company, saltando la mediazione dei giornali e delle stesse agenzie di pubblicità”, viene ancora sottolineato. Prendono sempre più piede nuove strategie e tecnologie di mercato, come ad esempio, il programmatic buying, ossia la compravendita softwarizzata di spazi pubblicitari: una fetta che cresce sempre di più, tanto che oggi negli States un quinto della pubblicità su display passa proprio attraverso il programmatic buying, con una prospettiva a breve termine (un quadriennio) di raggiungere addirittura quota 50 per cento. Cifre e percentuali da noi ancora sconosciute, visto che tale “canale” è per ora attestato intorno al 5 per cento, con una previsione massima – sempre a breve – del 9/10 per cento.
Nel nostro Paese la pubblicità on line fa segnare dati di crescita, unica nell’universo dei media. Con un fatturato da 1 miliardo e 700 milioni, siamo al quinto posto in Europa, dietro Gran Bretagna (quasi 7 miliardi e mezzo), Germania (4 e mezzo), Francia (3 e mezzo), Russia (1,8), ma davanti ad Olanda, Svezia e Spagna attestate intorno al miliardo. All’interno del web, sempre in testa (ma in calo relativo) i banner (superano i 600 milioni di euro), seguiti a ruota da “search”, molto distanziate le altri voci via internet (video, classified, social e mail). Sul fronte dei banner, secondo gli analisti, sono in crescita quelli venduti in “modalità automatica”. Si tratta – viene fatto notare – della cosiddetta pubblicità programmatica, una tipologia che nel 2013 ha raccolto una trentina di milioni di euro ma in crescita esponenziale. L’idea base è – in sostanza – di adattare sempre più il profilo della pubblicità a quello del potenziale utente, del consumatore; una sorta di osmosi, una interazione sempre più penetrante. Spiegano ancora gli esperti di web & marketing: “occorre che una piattaforma conosca in tempo reale chi è connesso in un certo momento con un certo sito, e quindi spedisca nello spazio dedicato al banner all’interno del sito, ma visibile solo per quell’utente, l’inserzione pubblicitaria più adatta al suo profilo”. Una sorta di psico-marketing, per la gioia del consumatore-utente ma soprattutto dell’azienda produttrice-fornitrice. Ad alzare il velo sui rischi di una mondo a stelle e web è lo studioso del Mit Ethan Zucherman, autore di un saggio dal significativo titolo “The Internet’s Original Sin”. Secondo Zucherman “gli utenti pagheranno per i servizi che apprezzano per una semplice ragione: pagare in anticipo per ricevere dei servizi – piuttosto che averli gratuitamente ma pieni di pubblicità – potrebbe fermare e anche invertire la tendenza verso un web centralizzato, finanziato dalla pubblicità e pesantemente controllato”.
Critica il presente e guarda alla prospettiva un altro grosso esperto delle nuove forme di comunicazione, Evgeny Morozov: “quanti di noi vogliono vivere in un mondo in cui l’accesso a molti beni e anche ad altre persone – esattamente quel che la nostra comune infrastruttura digitale ci permette di fare – deve essere mediato dal mercato, si tratti di pubblicità o di un contributo?”. E prosegue: “considerare di pubblica utilità siti che offrono servizi base – social network, email, bookmark – significa anche che possiamo pensare a mondi alternativi di possederli, amministrarli e finanziarli”. “La pubblicità non è il peccato originale di internet, ma il neoliberismo potrebbe senz’altro esserlo”. Per questo, sostiene, occorre “reinventare il nostro ambiente digitale”, “creando istituzioni di cui possiamo fidarci”. Mission impossible, o quasi. Ma val certo la pena di provarci.
Sulla stessa lunghezza d’onda alcune considerazioni – e analisi – di Ilvo Diamanti, poi calate nel nostro panorama. “Occorre cautela nel celebrare la “libertà” della Rete. Sia perchè (come rammenta Evgeny Morozov) è, spesso, sottoposta a interferenze e controlli. Sia perchè la stessa libertà di accesso rende difficile verificare le informazioni che circolano”. Una fresca ricerca Demos-Coop delinea il profilo delle nuove vie di comunicazione nel traversano il nostro Paese, con un’informazione tradizionale in via di progressivo prosciugamento e un web in costante ascesa, con la proliferazione, oggi, di una sorta di “argonauta” degli spazi ibridi, mezzo antenna (tivvù, che ancora tira e rastrella pubblicità), mezzo web. Un’informazione liquida, in fase di continuo assestamento, sorta di lava che man mano si accosta sì alle soglie dei palazzi del Potere – per vigilare su di essi, secondo il verbo della Rete, nello spirito para grillino – ma forse, poi, si perde per mille rivoli senza più trovare una Sintesi. Nuove vie verso la Democrazia? O mere illusioni di una Partecipazione solo Virtuale?
Consigli per i naviganti, nei mari delle nuove comunicazioni. Guardate il film State of Play, lo hanno dato un paio di volte su Iris tra fine novembre e primi di dicembre. Dentro c’è una sorta di bussola per capirci qualcosa tra giornalismo, blog, web (ma anche potere, corruzione, polizie parallele – siamo negli States – e via di questo passo). Dal Morandini, il prezioso video vocabolario, due ottimi motivi per vederlo: fotografa “la grave crisi di vendita del giornalismo stampato”; “confuta l’ottimismo di chi vede nella complessa e cannibalica blogosfera di Internet un nuovo e indiscutibile strumento d’informazione, partecipazione, mobilitazione e denuncia”. Da “non perdere i titoli di coda”, nota con grande acume Morando Morandini: e per chi ha vissuto qualcosa del vecchio e sano giornalismo d’inchiesta (personificato da un gigantesco Russell Crowe) quei bianco neri finali sono da brividi (non nel senso hitchcockiano).